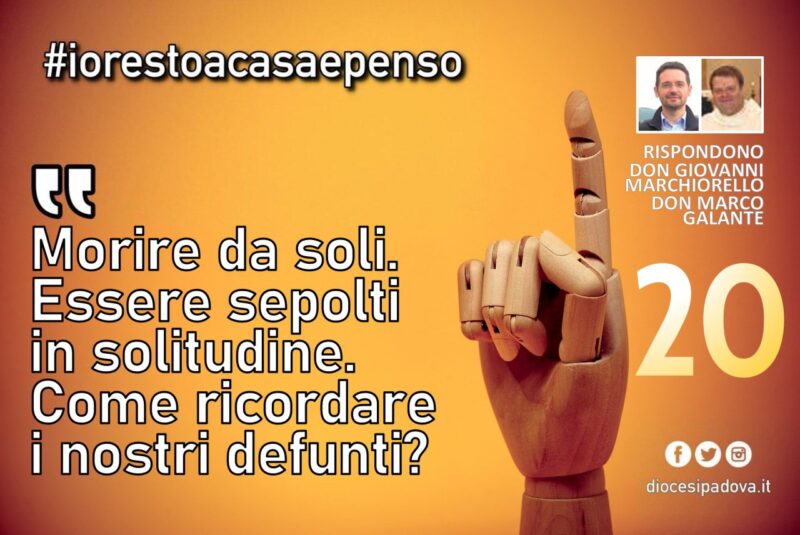Lunedì 30 marzo ore 8:23. Squilla il cellulare e sul display compare il nome “mamma”. Qualche secondo e l’anticipo: «È morta zia Franca?». Silenzio e poi lei di getto: «Mi dispiace perché è morta sola». La sua voce si rompe. E poi: «Non ho potuto salutarla». Si rompe ancora e così la mia.
Chiudo la telefonata e non nascondo a me stesso alcune lacrime, ricordando che sono lacrime spese bene.
Mi trovo seduto sulla sedia, nel mio ufficio, e dietro di me, in alto, c’è una croce con l’Uomo crocifisso, un regalo che proviene dalla comunità di Bose. In un baleno quell’immagine è sostituita da un’altra, che si affaccia dentro di me, un’opera di Arcabas: Hommage a Bernanos. La metto a fuoco, ricerco i soggetti e i contorni.
Il grande polittico raffigurante Gesù crocifisso ha come “corona” quattro pannelli; essi rappresentano tutto il male “virale” nel mondo, anche all’interno della Chiesa.
C’è un particolare: sotto la croce una bimba, seria, concentrata, che ci guarda e invita ognuno a leggere il suo cartello. In questo periodo bimbi e ragazzi ci hanno regalato disegni e dipinti con l’arcobaleno e la scritta “andrà tutto bene”. La ragazzina ha dipinto altre parole: Ego sum. Nolite timere. Io ci sono Non temere. Non sono sue, ma di colui che le sta sopra, con lo sguardo chinato su di lei. E lei le prende, le distende e ce le consegna.
Attorniati da tanto strazio, ci raggiunge una speranza anch’essa ferita.
Si può sperare mentre le persone care muoiono sole? Si può sperare mentre solo pochissimi le possono accompagnare al passaggio, con un rito poco partecipato? Chi sta morendo può sperare in un ultimo sguardo o gesto, teneri e delicati, mentre supplicano con gli occhi di essere aiutati?
Questo morbo invisibile, ma anche ogni ingiustizia subita o provocata, può toglierci l’umanità?
È Venerdì Santo, ai piedi di Gesù crocifisso non c’è solo la ragazzina; l’evangelista Giovanni scopre altre due persone: Maria e il discepolo amato da Gesù.
A Maria, sussurrando dice: «Ecco tuo figlio!» e con lo sguardo indica chi le sta accanto. E poi al giovane uomo, indicando lei con lo stesso sguardo: «Ecco tua madre!».
È una consegna. Ti consegno a lui; ti consegno a lei.
Con una nota: maneggiare con cura. Come siamo soliti leggere su involucri di contenuto prezioso e fragilissimo. “Maneggiare con cura” significa: lì dove non possiamo esserci, ci sia sempre almeno qualcuno che ci rappresenti.
Maneggiare con cura significa ancora: riprendi alcune parole della vita e della relazione, ripuliscile, igienizzale, dà loro una qualità che prima ti sfuggiva e regalale come fossero nuove.
Il venerdì precedente la morte della zia, mia cugina mi invia un whatsapp: «Spero per lei che non soffra. Purtroppo, non possiamo starle vicino. Sono sicura che gli operatori sanitari saranno in grado di fare il loro operato in modo dignitoso». Ecco una piccola speranza che emerge dalla disperazione.
Un attracco di fiducia accordata. Ma ce n’è un altro a cui non possiamo rinunciare. Lo dice bene Rubem A. Alves: «La vita si perde quando noi non galleggiamo più sul profumo della bontà di Dio. Sai galleggiare sull’acqua? È necessario abbandonare il corpo. Ammorbidire tutto. Credere che l’acqua sarà amica. E ci lasciamo andare»”.
Quanta umanità regalata e moltiplicata anche in questi giorni di astinenze e solitudini.
don Giovanni Marchiorello, parroco di Vigodarzere
Fa impressione come questo virus abbia la forza di isolarti dagli affetti più cari nel momento in cui ce ne sarebbe più bisogno. Ne parlavo qualche giorno fa con un medico dell’ospedale che in questi giorni è in prima linea nel seguire le persone che si ammalano. E la risposta è stata: «penso alla solitudine di Maria davanti alla morte del Figlio in croce. Quanta forza interiore deve avere avuto nel rimanere lì a vedere il Figlio che muore e non poter fare nulla. Come ha fatto a rimanere lì davanti senza lasciarsi andare all’istinto materno di “arrampicarsi” su quella croce per fare qualcosa che sollevi il dolore di quella morte atroce: una carezza al Figlio, un bisbiglio per dire al morente ci sono io qui con te, non avere paura c’è tua mamma».
Mi ha impressionato questa sottolineatura. Non ci avevo mai pensato. Eppure è vero che Maria ha dovuto guardare da lontano la morte del Figlio. Tutti avremmo bisogno nel momento del passaggio di avere una mano amica che ci conforta e ci dà forza. Ma è davvero tutto? Forse no. La distanza di Maria mi fa pensare al tema del consegnare. Dell’affidare. Del mettere nelle mani di Maria. In quel distacco dal Figlio mi fa venire in mente una madre che consegna, che affida, che rimette nelle mani del Padre la vita del Figlio.
C’è un principio pedagogico molto significativo a riguardo che mi ha sempre colpito: presenza, assenza, trasformazione. Perché vi sia cambiamento nella vita evolutiva ci vuole una giusta dose di presenza e di assenza. Nella misura in cui la presenza non è stata invadenza o dipendenza anche l’assenza ha il suo giusto diritto di esserci. Non è sempre detto che ci sia bisogno solo di presenza. A volte anche l’assenza aiuta la trasformazione.
La morte è il momento decisivo della nostra vita, la trasformazione più importante. Per noi cristiani non è la fine della vita ma l’inizio della vita in Dio. Dovremmo ricordarci per tutta la vita che nel momento della morte sarà il Padre a tenerci per mano e portarci con Lui.
don Marco Galante, cappellano ospedali riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta, Schiavonia
10 aprile 2020